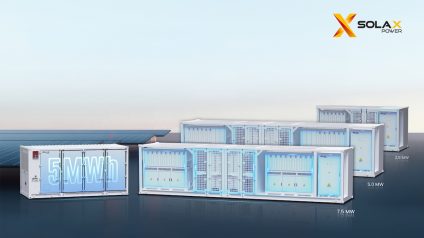Il cambiamento climatico sta spingendo l’acqua salata sempre più nell’entroterra: una nuova ricerca evidenzia il ruolo crescente dell’innalzamento del livello del mare e della diminuzione della portata fluviale nella salinizzazione delle acque dolci

L’acqua salata del mare penetra sempre di più nei fiumi e nei delta su scala globale a causa del cambiamento climatico. Ed entro la fine del secolo, il cuneo salino aumenterà ancora. L’intrusione salina riuscirà a risalire del 9% in più e questo tipo di eventi si verificherà il 25% più di frequente.
Lo ha calcolato uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori e pubblicato su Nature Communications. Lo studio è il primo a valutare congiuntamente gli effetti dell’innalzamento del livello del mare e del calo delle portate fluviali sull’intrusione salina, in 18 estuari distribuiti in tutti i continenti.
Intrusione salina: cos’è e quali impatti ha
L’intrusione salina si verifica quando l’acqua marina riesce a spingersi risalendo i corsi d’acqua dolce. Questo accade soprattutto nei periodi di siccità, quando la forza dei fiumi si indebolisce, ma il fenomeno è amplificato da fattori come l’innalzamento del livello del mare, la subsidenza e i cambiamenti nelle dinamiche delle maree e dei venti.
Le conseguenze possono essere pesanti: salinizzazione dei fiumi, contaminazione delle fonti idriche per uso potabile e agricolo, impatto sugli ecosistemi e riduzione della produttività delle colture non tolleranti al sale. In regioni costiere densamente popolate, l’intrusione salina minaccia direttamente la sicurezza idrica e alimentare.
Aumento della salinizzazione: le nuove previsioni
Come cambierà questo fenomeno a causa dell’impatto del cambiamento climatico? Lo studio ha calcolato che nell’89% degli estuari analizzati, la lunghezza dell’intrusione salina – cioè quanto lontano l’acqua salata riesce a spingersi nell’entroterra – aumenterà in modo significativo entro fine secolo. In qualsiasi scenario emissivo, e in particolare se si verificherà lo scenario climatico a più alte emissioni (SSP3-7.0).
In media, la lunghezza dell’intrusione salina crescerà del 9,1%, con picchi fino al 18,2%. Inoltre, gli eventi estremi di intrusione – quelli che oggi si verificano una volta ogni cento anni – potrebbero diventare 25% più intensi e molto più frequenti: in alcuni estuari si prevede che avranno un tempo di ritorno ogni 3,2 anni, o addirittura ogni 2 anni.
Il ruolo del cambiamento climatico
Dati che sono alimentati principalmente da 2 fattori: la diminuzione delle portate fluviali, legata all’aumento dei periodi di siccità, e l’innalzamento del livello del mare, che spinge l’acqua salata più facilmente all’interno.
Lo studio quantifica per la 1° volta il peso relativo di questi due meccanismi. Il risultato? L’innalzamento del livello del mare ha un impatto doppio rispetto alla riduzione della portata dei fiumi nella spinta dell’intrusione salina verso l’interno. In media, l’aumento della salinità dovuto al livello del mare è del 6,6%, contro il 3,5% legato al calo dei flussi fluviali.
Impatti concreti: dai raccolti all’acqua potabile
Gli effetti della salinizzazione dei fiumi si stanno già facendo sentire. Nel 2023, la siccità estrema che ha colpito New Orleans ha costretto le autorità statunitensi a costruire una barriera d’emergenza per evitare che l’acqua salata contaminasse le riserve idriche della città. In Olanda, durante l’estate del 2018, il cloruro ha superato i limiti per l’acqua potabile per 75 giorni consecutivi in uno dei principali rami del delta Reno-Mosa.
Tutto ciò riguarda anche l’Italia e il Po in particolare. Nel 2022, durante la fase più intensa della siccità che ha colpito la penisola nel 2021-23, il cuneo salino del Grande Fiume è risalito fino a 40 km dalla foce.
Se non si adottano misure di adattamento, i rischi per la salute pubblica, l’agricoltura e l’equilibrio degli ecosistemi potrebbero moltiplicarsi. Secondo i ricercatori, sarà fondamentale ripensare la gestione delle risorse idriche: accumulo di acqua piovana nei periodi umidi, riuso delle acque grigie e introduzione di colture resistenti al sale sono alcune delle soluzioni prospettate.